Voci da mondi diversi. Israele
Zeruya
Shalev, “Dopo l’abbandono”
Ed. Frassinelli, trad. Elena Loewenthal,
pagg. 472, Euro 18,00
Una donna si è appena separata dal marito, è
stata lei a volere la separazione, resterà nella loro casa con il figlio di sei
anni, nonostante l’evidente sofferenza del marito e del bambino. Il tempo di
adattamento sarà lungo, lei cercherà di tornare sui suoi passi, poi incontra
uno psichiatra, se ne innamora e va a vivere con lui. Le difficoltà aumentano
con la famiglia allargata, difficile evitare le gelosie tra i due figli di lui
e quello di lei, arduo trovare del tempo da soli. L’amore non è mai perfetto.
INTERVISTA A ZERUYA SHALEV
E’
una storia tormentata che lascia un segno nel lettore, quella raccontata dalla
scrittrice israeliana Zeruya Shalev nel suo nuovo romanzo “Dopo l’abbandono”
che completa una sorta di trilogia sull’amore ai nostri giorni, come indicano
in maniera allusiva pure i titoli dei libri precedenti, “Una relazione intima”
e “Una storia coniugale”. Il primo, “Una relazione intima”, era una rovente
storia di passione e sesso tra una ragazza e un uomo dell’età di suo padre;
“Una storia coniugale” raccontava della dolorosa separazione di una coppia
suggerendo, con l’accostamento dell’articolo “una” al nome e all’aggettivo, che
questo sia l’esito banalmente normale di un matrimonio; ancora una separazione
seguita da un nuovo innamoramento e dal formarsi di una nuova coppia in “Dopo
l’abbandono”. Questa volta però quello che noi lettori avvertiamo come il personaggio
principale è un bambino di sei anni, Ghili, anche se la voce narrante, le
emozioni e i pensieri esplorati sono quelli della sua mamma, Ella, che ha
appena lasciato Amnon, il padre del bambino.

descrive,
riferisce dialoghi e parole dette da lei e da altri, in un flusso continuo non
virgolettato che comunica
un senso di urgenza e immediatezza, ma è la vocetta
del bambino che si distacca dalle altre, ad iniziare dalle parole con cui il
libro incomincia, “Sono morto, grida, la voce accaldata, il suo corpicino si
dibatte sotto i miei occhi, sono completamente morto, morto per sempre, la
bocca aperta scopre i tremuli denti da latte, sospesi sul nulla.”: è il giorno
“dopo” la separazione dei genitori,
quel terremoto famigliare di un’intensità
pari a quello avvenuto quattromila anni prima nell’isola Santorini e avvertito
fino in Egitto, come ci viene di continuo rammentato sia da Ella sia da Amnon,
entrambi archeologi, in quello che è
un contrappunto storico metaforico
dell’intera vicenda.
La
paura dell’abbandono che prova Ghili ci fa male e ci porta a riflettere sui
diritti degli adulti a modificare la propria vita alla ricerca della felicità-
“pensavo che avevi deciso di lasciare me come hai fatto con papà”, dice il
bambino dopo che Ella ha tardato ad andare a riprenderlo a casa dell’amico. Ci
fanno male il suo disagio, la sua infelicità nel ritrovarsi ad essere un
bambino a metà tra due genitori, che non si sente più ricco perché ha due case
e due stanze, e neppure più amato perché ha un genitore alla volta tutto per
sé. Perché invece ha nostalgia della mamma quando è con il papà e del papà
quando è con la mamma. Perché ha solo sei anni e vorrebbe avere il bacio di
entrambi prima di andare a letto. Perché affrontare un cambiamento di casa a
sei anni, e non con mamma e papà ma per andare a vivere con un uomo che è uno
sconosciuto e i due figli di questo, è inesplicabile.

I rapporti umani sono
difficili, questo è quanto Zeruya Shalev vuole dirci. Si deve scavare in
profondità, come fanno gli archeologi nelle loro ricerche, per capire le
motivazioni dei nostri comportamenti- il padre tiranno e dominatore di Ella,
quello ammalato di mente dello psichiatra Oded, nuovo compagno di Ella, un
blocco della crescita di Ella che si collega, in qualche modo, con il suo
infantilismo. Difficili i rapporti tra genitori e figli quanto quelli di
coppia- almeno dopo che è passato l’incanto dell’innamoramento-, ancora più
difficili all’interno dei nuovi legami quando gli equilibri sono precari: i
figli del compagno non potranno mai essere come i propri, ed è così facile
invece farsi del male- basta dire ad un bambino “non mi piacciono gli orsi”,
quando è un orsetto di peluche che serve da tramite d’affetto, per respingere
il bambino insieme al suo orso. Eppure la vita va avanti e bisogna coglierla a
piene mani, con il suo bagaglio di felicità e infelicità, conquiste e
sconfitte- è questo che sembra dirci il funerale di un’amica in chiusura del
libro. Con la domanda colma di stupore di un altro bimbetto issato sulle spalle
del padre, “ma non la vedrò più la mamma?”. Stilos ha intervistato Zeruya
Shalev, che è nata in un kibbutz nel 1959 e vive a Gerusalemme.
“Dopo
l’abbandono” chiude una trilogia di romanzi che parlano di donne e tuttavia
sono diversi dalla tradizionale letteratura femminile: quale era il suo piano
quando ha iniziato a scrivere il primo, “Una relazione intima”?
Non
avevo progettato di scrivere una trilogia, non mi piace progettare, credo
nell’ispirazione- scrivo poesia e scrivo anche la prosa come fosse poesia.
Naturalmente devo conoscere i miei personaggi e in che direzione andrà il
libro, ma mi piace sorprendermi e trovarmi in un’avventura: scrivere è
un’avventura per me. D’altra parte non penso sia una vera trilogia, i libri
sono indipendenti l’uno dall’altro, solo quando ho scritto quest’ultimo mi sono
resa conto che tutti e tre insieme creano una sorta di trilogia e non tanto
perché al centro c’è un personaggio femminile, perché penso che gli uomini
conoscano le stesse emozioni e io scrivo della condizione umana e non solo di
quella femminile. Descrivo la complessità dei rapporti ma, prima di tutto, dei
rapporti tra l’individuo e se stesso, scrivo dell’amore per noi stessi e non
solo per un altro. Al centro dei tre libri ci sono le emozioni basilari, la
relazione con i genitori, con il marito o il compagno, con i figli. I libri
sono una trilogia nel senso che sono una ricerca sull’amore moderno e sulla
famiglia moderna. E poi hanno in comune la voce, lo stile, che è molto intenso
in tutti e tre, inquieto. Per me è importante perché sento che questa è la mia
voce e la voce crea il dramma più della trama. E in tutti e tre ho colto tre
donne diverse in un momento di crisi famigliare e ho cercato di vedere come si
comportano in queste crisi.
Il
titolo originale di “Dopo l’abbandono” è “Thera”, uno dei nomi dell’isola di Santorini.
Il tema dell’eruzione del vulcano, così come quello dell’archeologia, sono la
spina dorsale del romanzo, le due grandi metafore per quello che sta
succedendo?

Sì, ho pensato molto alla scelta di una professione
per la mia protagonista e mi sono resa conto che fare l’archeologa era l’unica
cosa possibile per lei, perché è sempre occupata con il passato e ha la tendenza a scavare e a
trovare prove per quello che vuole, a fare ricerche sulla sua vita: Ella è come
un archeologo dell’anima. Mi è capitato di leggere di questa eruzione a Thera e
ho pensato che fosse la metafora giusta perché mostra visivamente la maniera in
cui lei tratta il divorzio: è lei che prende l’iniziativa ma poi se ne pente,
il suo comportamento è estremo come un’eruzione. La sua famiglia è l’isola e
l’eruzione del vulcano viene da dentro di lei. Questo misto di passato e del
potere di distruzione ma anche dell’opportunità di una nuova vita mi è parso la
metafora più giusta per la sua storia.
Quando
Amnon incontra Ella per la prima volta, le dice che l’ha già vista, che
assomiglia ad un dipinto in Thera conosciuto con il nome di “la parigina”: i
comportamenti umani sono sempre uguali nei secoli e millennii?
Non
ci avevo pensato, ma è un’idea nuova e interessante. In realtà volevo fare in
modo che per lui non fosse un incontro nuovo, nel momento in cui vede la
somiglianza di lei con “la parigina” è come se lui l’avesse già incontrata: è una
metafora del destino e avevo bisogno di questo legame con il tema dell’eruzione
del vulcano a Thera.
C’è un
altro tema storico a cui si accenna spesso, la fuga degli ebrei dall’Egitto. E’
collegata in qualche maniera con la storia privata che stiamo leggendo?
Cerco
sempre di trovare dei legami tra la storia nazionale e quella famigliare. Se
credi nella storia dell’Esodo- e molti storici dicono che non è vera, ma a me
non interessa la verità storica- puoi trovare un legame tra la distruzione
dell’isola di Thera e l’Esodo, perché le conseguenze di questa eruzione sono
simili alle piaghe d’Egitto descritte nel Vecchio Testamento. E’ una maniera
privata per Ella di interpretare il disastro che la libertà può provocare,
perché è vero che gli ebrei sono diventati liberi una volta usciti dall’Egitto
ma hanno sofferto per la loro libertà, forse ancora di più che durante la
cattività: in questo modo Ella cerca la maniera di spiegare a se stessa la
storia della sua famiglia. Ella si chiede se proprio doveva distruggere la
famiglia, perché mai lo ha fatto. Si pone molte domande ma ci sono poche
risposte; Ella cerca risposte nella storia antica, cerca di convincersi che ha
fatto la cosa giusta, perché la lezione del passato è che dal disastro può
nascere la libertà.
Ella
non è un personaggio simpatico. All’inizio stiamo dalla sua parte ma,
proseguendo la lettura, non più. Perché? Perché ha fatto di una donna egoista e
infantile il personaggio principale del libro?
L’ho
fatto di proposito. E’ facile creare un personaggio con cui identificarsi ma io non voglio che i lettori amino Ella,
voglio mostrare una personalità umana. Chiedo al lettore di non giudicarla ma
di seguirla, con le sue debolezze- siamo tutti umani e lei cerca di affrontare
un momento difficile. Ella è egoista perché è infelice, è infantile ma se fosse
matura non ci sarebbe nessuna storia. Cerco dei personaggi umani con molte
debolezze, così posso accompagnarli a diventare più maturi, voglio che impari;
altrimenti, se Ella sapesse tutto, non potrei scrivere di lei.
Stranamente
il carattere più “forte” tra i personaggi è quello di Amnon, il marito
abbandonato che si rivela essere il migliore, anche se all’inizio sembrava “il
cattivo” della situazione…
Ha
ragione, penso sia una delle mie maniere di mostrare la complessità della
situazione. E’ facile lasciare un marito debole o stupido che non si apprezza,
ma volevo che Ella lasciasse un uomo da rimpiangere se no non ci sarebbe
problema. Volevo mostrare come lui cambi; per lui la separazione è l’opportunità
di svilupparsi come uomo e come padre e lui è capace di cogliere questa
opportunità. Amnon mostra anche a Ella e a Oded come superare le difficoltà e
penso che abbia ragione quando dice che è il più forte. Ecco perché è difficile
per Ella; quando si rende conto che Amnon vale più di quanto pensasse, capisce
anche che ha perso molto. E’ buffo, ma pare che in Israele molte lettrici ci
abbiano ripensato e non abbiano divorziato, dopo aver letto il romanzo.
Le voci
dei bambini sono tenere, a volte buffe e a volte strazianti. Penso che lei
debba avere dei figli per rendere le loro voci così convincenti. Anche Lei è
passata attraverso una separazione: come hanno reagito i suoi figli alla sua
separazione?
Sono
contenta di essere riuscita a rendere bene la voce dei bambini- sono molto
vicina ai miei figli e ho cercato di imitare la voce di mio figlio in quella di
Ghili. Passo molto tempo con loro e cerco di identificarmi con loro, è come se
sentissi le loro voci dentro di me. La mia storia però è diversa: quando mi
sono separata da mio marito mia figlia aveva solo 4 anni ed era diversa da
Ghili, era troppo piccola. Non ho attraversato questo processo penoso, però
conosco alcune delle emozioni di Ella e ho usato dei ricordi di quel tempo-
conosco i tragici sentimenti di una famiglia spezzata.
Una
morte chiude il libro: la brevità della vita è qualcosa che dovremmo tenere
sempre presente nelle difficoltà quotidiane?

In
un certo senso sì, volevo finire con un’esperienza che tutti e quattro i
personaggi principali condividessero: erano così impegnati con la loro vita e
alla fine si trovano insieme con una esperienza che non è la loro. Volevo che
uscissero da sé davanti ad un dolore universale. La morte di una donna giovane
è la morte delle illusioni, perché questa donna è simbolo della madre e della
moglie perfetta. Ella l’ha invidiata a lungo, ricorda la festa a cui la donna
aveva invitato tutti e adesso quella festa è diventata il funerale e mostra
l’illusione della perfezione. Ella deve separarsi dall’illusione per essere
matura e meno egoista, deve abbandonare l’illusione dell’amore romantico, deve
lottare per dei momenti di felicità. Alla fine Ella sa che non sarà molto
felice ma non è più così egoista, deve prendersi la responsabilità degli altri,
di suo figlio, dei figli di Oded, di Oded stesso. Capisce che questa avventura
della vita non ha anche fare con la felicità ma con il significato- la sua vita
sarà più ricca di significato.
Parlando
di morte: sappiamo che Lei è stata ferita in un attentato terroristico, qualche
anno fa. Nel romanzo Oded dice che non c’è luogo all’aperto che sia sicuro per
portarci i bambini. Le è rimasta questa paura, del pericolo di andare ovunque?
Come si convive con questa paura?
Vivevo
nella paura anche prima di restare ferita nell’attentato- sono tanti anni ormai
che in Israele viviamo con la paura, dalla seconda Intifada, nel 2000. Ci sono
stati dei periodi in cui avevo paura persino a mandare i bambini a scuola. Tre
anni fa camminavo sul marciapiede- andavo sempre a piedi perché avevo paura di
prendere un autobus- ed è esploso l’autobus che mi passava accanto: quando è
destino…Mia figlia tuttora corre via quando sente un autobus che si avvicina. E
tuttavia si impara a convivere con la paura, a calcolare quale strada sia
meglio fare…
Eppure
non c’è quasi nessun riferimento nei suoi romanzi alla eterna guerra in
Israele…
E’
vero, ci sono pochissimi cenni nascosti alla situazione della vita in Israele;
Oded ad un certo punto parla del trauma di un paziente- è un accenno
piccolissimo autobiografico alla mia paura e a quello che mi è successo. Ho
bisogno di questa separazione dalla realtà israeliana nella mia scrittura. Il
pericolo è nello sfondo ma non voglio scriverne perché cerco nuove risposte
nella mia scrittura. La letteratura è diversa dal giornalismo e, se scrivo
della realtà, è troppo immediato e non mi interessa descrivere la realtà
quotidiana in Israele. Cerco la profondità dell’animo, non so come fare
letteratura dal terrore- è troppo tragico. Cerco piuttosto le tragedie nascoste
nella situazione quotidiana della vita di coppia, della maternità. Non voglio
scrivere del tragico conflitto o della tragedia palestinese.
La recensione e l'intervista sono state pubblicate sulla rivista letteraria "Stilos"
.jpg) |
| copertina dell'edizione del 2007 |






















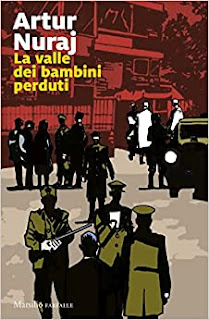

















.jpg)